
a cura di Vera Fisogni
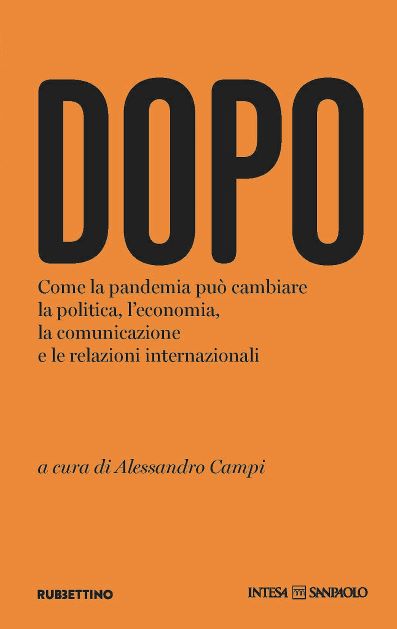 Confine e frontiera sono le parole-chiave del post-emergenza Covid-19. La pandemia ha infatti segnato una linea netta tra il prima e il dopo il ogni ambito. Al “Dopo” è dedicato il volume curato dal professor Alessandro Campi, ordinario di Scienza politica nell’Università di Perugia e direttore della “Rivista di Politica”. Sottotitolo del saggio, edito da Rubbettino, (finanziato da Intesa Sanpaolo): “Come la pandemia può cambiare la politica, l’economia, la comunicazione e le relazioni internazionali”.
Confine e frontiera sono le parole-chiave del post-emergenza Covid-19. La pandemia ha infatti segnato una linea netta tra il prima e il dopo il ogni ambito. Al “Dopo” è dedicato il volume curato dal professor Alessandro Campi, ordinario di Scienza politica nell’Università di Perugia e direttore della “Rivista di Politica”. Sottotitolo del saggio, edito da Rubbettino, (finanziato da Intesa Sanpaolo): “Come la pandemia può cambiare la politica, l’economia, la comunicazione e le relazioni internazionali”.
Professore, ha ancora senso la parola “normalità” dopo l’emergenza coronavirus?
La normalità è la nostra vita ordinaria, le cose che facciamo tutti i giorni. Sarà dunque normale, finita l’emergenza sanitaria, convivere con questo virus, o per meglio dire con l’idea che, se anche si dovesse trovare un vaccino specifico contro il Covid-19, dobbiamo abituarci all’idea che altre pandemie potrebbero prima o poi scoppiare su scala globale. La nostra normalità dovrà consistere nel non farsi più trovare impreparati da simili eventi tutt’altro che straordinari.
Davvero nulla sarà più come prima? Che cosa è stato cambiato, più di tutto, da Covid-19?
Prima che sui cambiamenti materiali, che pure sono stati molto grandi, parlerei di quelli legati alla nostra sfera emotiva e psicologica. Abbiamo realizzato, nell’arco di poche giorni, tutta la nostra estrema fragilità esistenziale e le contraddizioni del nostro sistema di vita. Sono cambiate (ovvero sono state messe a dura prova) le nostre relazioni sociali e affettive. Peraltro con effetti che ancora non sappiamo calcolare. Vedo in giro persone che sembrano essere state molto provate dal lungo isolamento coatto, c’è molto nervosismo, se non rabbia repressa.
Dal benessere all’incertezza più totale. Cosa deve insegnarci il fattore di estrema instabilità che ha caratterizzato la pandemia?
Che bisogna programmare meglio il futuro, senza la pretesa (ovvero l’illusione) che le cose del mondo siano destinate ad andare sempre meglio o per il verso giusto. Abbiamo dimenticato la lezione della storia, che ci dice che l’imprevisto e la tragedia, per le collettività come per gli individui, sono sempre dietro l’angolo. Colpisce il fatto che società così pervase dalla tecnologia, che a livello di fantasia sono state capaci di immaginare ogni possibile scenario di catastrofe, a livello di vita reale non abbiano messo in conto la possibilità di un simile evento, peraltro largamente annunciato (se non altro dalla cinematografia). Su questo c’è stata una colpa grave della politica e delle classi di governo: tutte concentrate sul presente, sul consenso immediato, ma incapaci di ragionare sui tempi lunghi. Incapaci soprattutto di prendere provvedimenti che possano apparire controcorrente o non in sintonia con gli umori dei cittadini.
Alcune libertà fondamentali sono state congelate nell’emergenza: pensiamo al lockdown. È cambiato qualcosa anche nell’idea di democrazia e di libertà, durante l’emergenza? O meglio, la pandemia ha contagiato in qualche modo la democrazia.
Le masse impaurite diventano conformiste e obbedienti. Dovendo scegliere tra la vita e la libertà gli uomini preferiscono senz’altro la prima. Su questo istinto di sopravvivenza politici senza scrupoli potrebbero costruire campagne di allarme sociale che a loro volta potrebbero portare ad una concentrazione del potere in mani sempre più ristrette, ad una riduzione delle normali procedure costituzionali e ad una limitazione crescente delle libertà individuali. In nome dell’emergenza, come si è visto, si può giustificare qualunque cosa, anche misure che in altri contesti avremmo definito da “stato di polizia”. Adottate peraltro nel nome della “salute collettiva” e dunque difficilmente contestabili nel merito e, a maggior ragione, nel merito. Il rischio di una deriva illiberale delle democrazie in effetti esiste.
Tra gli Stati s’è scatenata una corsa virtuosa a scambiarsi dati e a collaborare per fermare il contagio. Quale cooperazione, e tra quali comunità, o quali azioni comuni all’umanità è giunto il momento di scegliere?
C’è stata cooperazione, ma forse ancora più forte è stata la competizione. Gli Stati si sono scambiati informazioni sanitarie e si sono prestati aiuti, ma non dimentichiamo la corsa a chiudere le frontiere, i sequestri alle dogane di mascherine, respiratori e altro materiale medico (quando si è capito che servivano per sé), la corsa a prodursi il vaccino prima degli altri (questo ovviamente riguarda solo gli Stati più forti e avanzati). Anche in Europa lo spettacolo, soprattutto nelle prime settimane, non è stato particolarmente identificante, con l’Italia lasciata sola e con gli altri Paesi che, una volta colpiti anch’essi dai contagi, si sono mossi ognuno per conto proprio. Ci si chiede se, passata la Grande Paura, si tornerà ad essere più cooperativi e solidali su scala globale. Non ci giurerei. Quella che si annuncia sembra piuttosto una nuova corsa all’egemonia nel segno della potenza. Basta vedere a come sta evolvendo la nuova “guerra fredda” tra Stati Uniti e Cina.
Smart working, didattica a distanza, webinar. Il mondo è diventato a velocità esponenziale una Community Web. Potremo più farne a meno?
Questa è stata una delle grandi novità portate dalla pandemia, destinata a durare e a produrre conseguenze. Avevamo a disposizione una tecnologia che semplicemente non utilizzavamo in tutte le sue potenzialità. Naturalmente, la didattica a distanza o il lavoro da remoto non si possono praticare in condizioni di emergenza, come abbiamo fatto in queste settimane. Avendo capito che si può sia insegnare sia apprendere sia lavorare stando a casa dobbiamo adesso provare ad organizzare queste attività in modo razionale. Se lavoro a casa, non mi serve solo un computer da tenere sul tavolo da cucina. Ho evidentemente bisogno di uno spazio lavorativo domestico: ciò significa riprogettare e ridisegnare anche i luoghi dove abitualmente viviamo, nella misura in cui diventano anche luoghi di lavoro. Con lo smart working di massa cambierebbero ovviamente la mobilità e i trasporti, come anche la rete dei servizi sociali. Ma sono tutte cose che vanno pensate e programmate, non possono essere subite come invece è accaduto. Stesso discorso per la didattica a distanza: si può fare ma i suoi contenuti e le sue modalità debbono essere pensati in forma nuova.
Dopo le ondate pestilenziali si è sempre affacciato un Nuovo Rinascimento, come anche lei ricorda. Cosa vede profilarsi?
Eviterei i paragoni storici impropri o troppo facili. Non c’è nessun automatismo tra una grande disgrazia storica e una rinascita creativa. Dopo le pesti del tardo Trecento è venuto il Rinascimento, ma ci sono voluti più di cent’anni. Se anche stavolta i tempi fossero gli stessi, ne godrebbero forse i nostri nipoti. Ricordiamo poi che dopo la spagnola del 1919-21 sono venute le dittature, la grande crisi del ’29 e la seconda guerra mondiale. Nel caso di questa pandemia, mi aspetto, più modestamente, uno sforzo di intelligenza collettiva che faccia tesoro di quel che è successo con l’obiettivo di organizzare meglio (e in modo meno iniquo) le nostre società. Si sono aperte sfide interessanti, ad esempio su come, per via del distanziamento fisico, dovremo ripensare l’organizzazione degli spazi urbani e dei luoghi di ritrovo collettivo. Senza aspettare un nuovo Leonardo da Vinci su questi e altri temi dovremo cominciare a spremerci le meningi.
Lo Stato sembrava confinato alla marginalità nelle dinamiche politiche. Invece è stato, anche in Italia, il principale player nell’emergenza. Un attore primario nell’economia e in campo sociale. La pandemia come sta cambiando gli equilibri geopolitici?
Politicamente il ritorno dello Stato mi sembra la vera novità di questa fase storica. Il bisogno di protezione e sicurezza (in primis sul versante sanitario) lo ha fatto tornare in auge, anche sul piano della politica economica. L’unica mia preoccupazione è che il ritorno della Stato finisca per trasformare, soprattutto nel caso italiano, nel ritorno dello statalismo: lo Stato elemosiniere, che distribuisce ricchezza pubblica in deficit in cambio di consenso politico, invece dello Stato regolatore e innovatore di cui avremmo bisogno. Pensiamo solo a quanto ci sarebbe da fare sul versante delle infrastrutture tecnologiche o della modernizzazione del nostro apparato burocratico-amministrativo.
Vede possibile la de-globalizzazione, un ritorno ai particolarismi politico-territoriali, all’autarchia socio-culturale e al protezionismo economico?
La globalizzazione stava già conoscendo una battuta d’arresto, che questa pandemia ha ovviamente accentuato. Ma ovviamente non si può tornare ad un’economia chiusa che peraltro nella storia non è mai esistita. Le filiere produttive sono ormai integrate su base globale. L’autarchia industriale o commerciale è del tutto irrealistica. Semmai dobbiamo anche in questo caso immaginare una globalizzazione meno anarchica e distruttiva di quella che abbiamo conosciuto, che non necessariamente deve risolversi – come qualche profeta immaginava – nella creazione di un mondo unico o unificato dal punto di vista dei valori, dei consumi e delle idee. Dobbiamo immaginare un mondo al tempo stesso globale e plurale, interconnesso ma anche capace di salvaguardare le proprie specificità territoriali, politiche e culturali.
Lei paventa che “il mondo nuovo” prenda il peggio del “mondo vecchio”, cosa intende dire?
Non credo che questa pandemia porterà alla costruzione di un mondo nuovo o completamente diverso dal precedente. Credo piuttosto che possa agire come acceleratore di processi e tendenze che erano già in atto. Nel bene come nel male. Pensiamo, per fare un esempio un po’ crudo, alla questione degli anziani. Sono morti a migliaia nelle case di cura e per questo ci siamo commossi e addolorati. Ma non è stata una fatalità: semmai l’esito, certamente tragico, di un modello sociale che noi stessi abbiamo voluto e che prevede che le persone espulse dalla vita attiva e produttiva, non potendo più stare in famiglia, vengano confinate in luoghi riservati dove ci illudiamo che godano di ogni protezione e confort. Continueremo con questa ipocrisia?
*Intervista apparsa su “La Provincia” (Como) il 15 giugno 2020







Lascia un commento