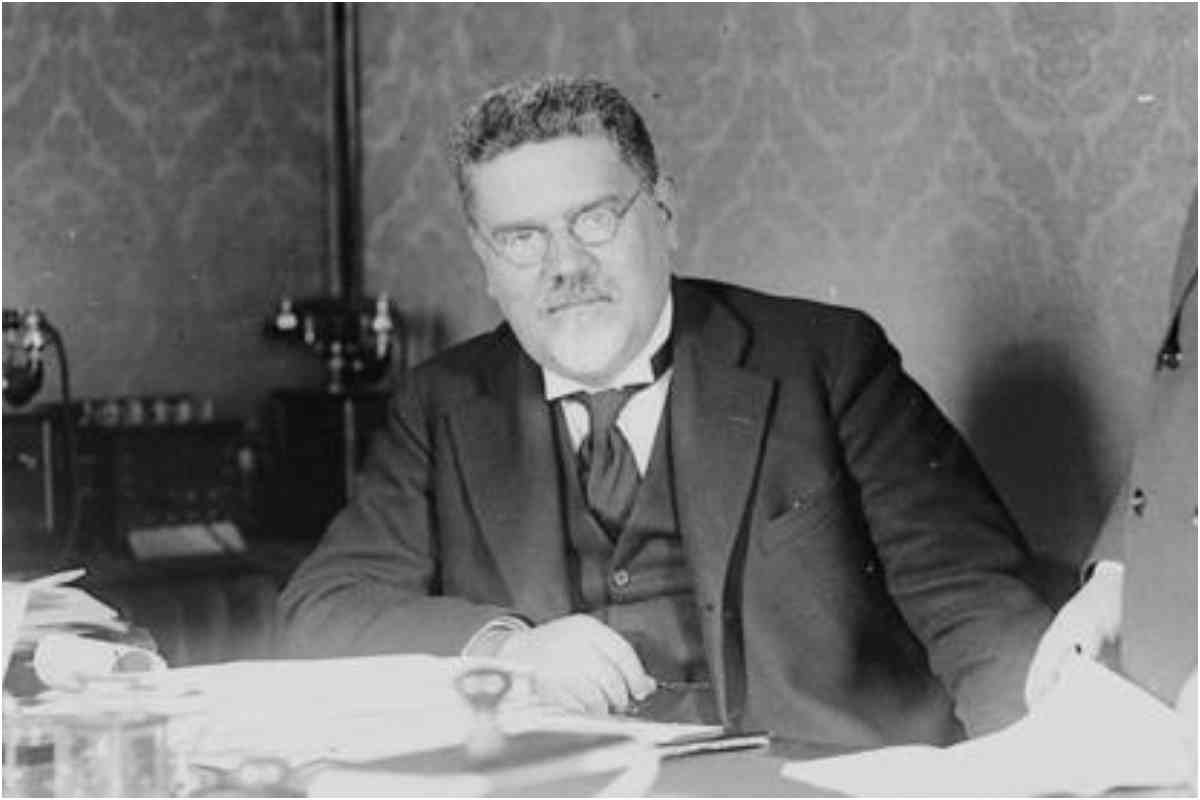
di Giuliano Gioberti
Il prossimo 29 maggio 2025 saranno 150 anni esatti dalla nascita di Giovanni Gentile. Il filosofo era infatti nato a Castelvetrano nel 1875 ed è stato assassinato a Firenze il 15 aprile 1944. Sulla sua morte il dibattito politico-storiografico è ancora molto acceso, così come ancora roventi sono le discussioni sulla sua eredità, sul suo ruolo come intellettuale e sul posto da assegnargli nella storia italiana. Nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche tra il Sindaco di Firenze Sara Funaro e il ministro della Cultura Alessandro Giuli sull’opportunità o meno di intestargli una strada nella città dove è stato ucciso e dove si trova sepolto.
Gentile fu un grande maestro, insieme a Benedetto Croce, o un traditore della cultura per opportunismo e pavidità? Quali sono stati i suoi rapporti col fascismo e, in particolare, con Mussolini? Per quali ragioni Gentile ha aderito alla Repubblica sociale italiana andando incontro a un destino per molti versi inesorabile e prevedibile. E come giudicare oggi il suo pensiero filosofico, la sua produzione come storico della cultura italiana e la sua attività come organizzatore culturale?
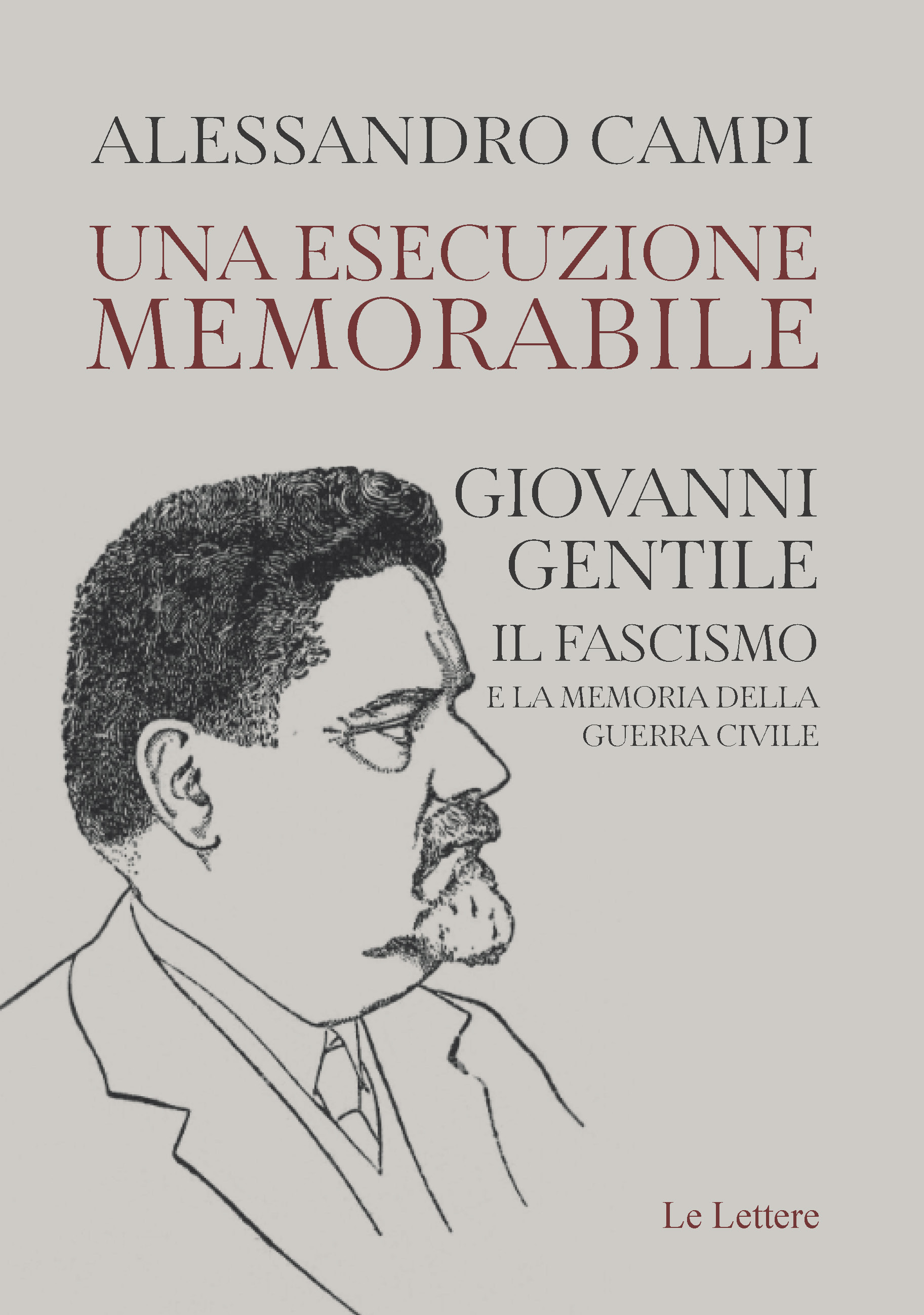 Sono alcuni degli interrogativi al centro del libro appena pubblicato da Alessandro Campi dal titolo Una esecuzione memorabile. Giovanni Gentile, il fascismo e la memoria della guerra civile, pubblicato dalla casa editrice Le Lettere di Firenze.
Sono alcuni degli interrogativi al centro del libro appena pubblicato da Alessandro Campi dal titolo Una esecuzione memorabile. Giovanni Gentile, il fascismo e la memoria della guerra civile, pubblicato dalla casa editrice Le Lettere di Firenze.
Il libro da un lato indaga la complessa trama di motivazioni e ragioni – ideali, congiunturali, storico-culturali, caratteriali – che, dopo l’8 settembre, spinsero Gentile ad aderire alla Repubblica sociale italiana: una scelta che lo avrebbe condotto a un consapevole e per molti versi inevitabile martirio.
Dall’altro, si interroga sulle implicazioni e i significati – sul piano politico-simbolico e storico-filosofico – della sua morte. Una morte per molti versi “necessaria”, attesa e inevitabile nel contesto della guerra civile che all’epoca dilaniava l’Italia.
Più in generale il libro prova a rispondere su come oggi, ottanta anni dopo la sua morte violenta, si possa affrontare una figura che rimane al tempo stesso tragica, ingombrante ma di indiscutibile spessore.
Ad Alessandro Campi (nella foto in basso)– professore di Storia delle dottrine politiche nell’Università di Perugia, direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e del trimestrale “Rivista di Politica” – abbiamo rivolto alcune domande.
Perché ha scelto di intitolare questo libro “Una esecuzione memorabile”?
L’espressione si trova nei Discorsi di Machiavelli. Per quest’ultimo i cambi radicali e violenti di regime, “da tirannide in repubblica o da repubblica in tirannide” come scriveva, sono sempre segnati da una morte eccellente o simbolica che fa da spartiacque tra il prima e il dopo. L’uccisione di Gentile nella storia italiana ha avuto esattamente questo significato. Con lui è finita l’Italia nazional-monarchica di matrice risorgimentale. Dalle ceneri del fascismo è nata una democrazia repubblicana le cui forze dominanti, cattolici e comunisti, non avevano più alcun legame con le idealità, le battaglie e le parole d’ordine che portarono all’unificazione dell’Italia.
In cosa si differenzia questo libro rispetto ai tanti usciti sull’uccisione di Gentile nel corso degli anni?
Sul delitto Gentile sono apparsi volumi importanti come quelli di Luciano Canfora, Antonio Paoletti e Luciano Mecacci, che però si sono incentrati quasi esclusivamente sulla questione dei mandanti e degli esecutori materiali di quel delitto. Questi autori hanno anche adombrato l’esistenza di misteri, zone d’ombra e responsabilità ancora non chiarite. A mio giudizio, invece, non c’è alcun segreto da scoprire. Gentile è stato ucciso da partigiani comunisti che nel contesto di una montante guerra civile consideravano pericolosi i suoi appelli alla pacificazione tra italiani. Gentile era un moderato e nelle guerre intestine, spietate per definizione, i moderati sono sempre i primi ad essere abbattuti.
Perché ancora oggi la figura di Giovanni Gentile suscita ancora tante divisioni e dibattiti?
Da un lato, perché l’Italia è rimasta una realtà settaria e rissosa, dove prevalgono, nella cultura come in politica, le logiche tribali e di schieramento. L’esatto contrario di quel che predicava Gentile, sostenitore dell’unità, dell’armonia, della collaborazione. Dall’altro, perché c’è chi ha evidentemente interesse a mantenere aperte certe tensioni e divisioni, come se la guerra civile nel corso della quale Gentile è stato ucciso, proprio a causa delle sue posizioni conciliatrici, non debba mai finire. Detto questo le polemiche sulle commemorazioni pubbliche da dedicare al filosofo sono diventate davvero stucchevoli. Oltre che inutili. Il suo posto nella storia d’Italia resta anche senza che gli si dedichino una rotatoria, una targa, un cippo o un francobollo.
Cosa rappresenta Giovanni Gentile oggi, a distanza di centocinquant’anni dalla nascita?
E’ stato, ricordarlo non è banale, il più grande filosofo speculativo del Novecento italiano. Tutt’altro che un pensatore provinciale come qualcuno si ostina a definirlo. E’ stato inoltre l’ultimo intellettuale che abbia avuto una visione organica, strategica e di lungo periodo della storia italiana. Basta guardare al suo programma di lavoro e ai suoi libri, nei quali ha minuziosamente ricostruito la trama di una cultura nazionale unitaria da Dante a Mazzini, passando per Bruno, Vico, Cuoco, Gioberti, Manzoni, Leopardi, Rosmini. Un tentativo grandioso che nessuno ha più tentato dopo di lui.
 Gentile è stato un grande organizzatore culturale, secondo lei qual è oggi il suo lascito maggiore.
Gentile è stato un grande organizzatore culturale, secondo lei qual è oggi il suo lascito maggiore.
Tutte le istituzioni culturali che Gentile ha fondato o diretto o sulle quali ha impresso il suo sigillo – dall’Enciclopedia italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dalla Domus Galileiana all’Ismeo, dal Centro di studi manzoniani all’Istituto italo-germanico, per non parlare ovviamente della sua riforma della scuola – gli sono sopravvissute. Cosa vuole dire? Che non erano state pensate per il fascismo e la sua macchina di propaganda, ma per l’Italia. La sua idea era costruire il sistema nervoso culturale di un Paese giunto da poco all’unità politica e statuale. E questo dimostra la sua capacità di guardare lontano, oltre le generazioni, esattamente quello che il mondo politico e quello culturale oggi non riescono più a fare.
Qual è dunque il significato che lei annette alla morte di Gentile: con quelle modalità e in quelle circostanze?
L’uccisione di Gentile è stata, nella storia italiana, uno spartiacque sul piano politico-culturale: “una esecuzione memorabile”, appunto, il tributo di sangue che era da pagare nel passaggio – liberatorio ma non privo di aspetti contradditori e paradossali – dall’Italia fascista nella quale Gentile, pur essendo un uomo del Risorgimento di formazione nazional-liberale, aveva creduto e svolto un ruolo da protagonista, all’Italia antifascista, molti esponenti della quale si erano formati proprio sugli insegnamenti di Gentile. La morte violenta del filosofo dell’attualismo, in altre parole, più che un enigma e un giallo a sfondo poliziesco – ovvero uno dei tanti misteri più o meno irrisolti di cui è piena la storia d’Italia del Novecento – rappresenta, secondo me, un episodio tragicamente rivelatore della complessità delle vicende – politiche, culturali, umane – che ne hanno caratterizzato lo sviluppo sino ai giorni nostri. Ed è il motivo per il quale, trascorsi più di ottant’anni dalla sua morte, il nome di Giovanni Gentile continua a risuonare nel profondo della memoria pubblica nazionale, come si vede dalle polemiche che periodicamente riesplodono intorno al suo nome.







Lascia un commento